La persona con Aids e il suo contesto di vita, 1992
Offrire e dare solidarietà, 1991
6 Ottobre 2014La realtà umana della malattia
6 Ottobre 2014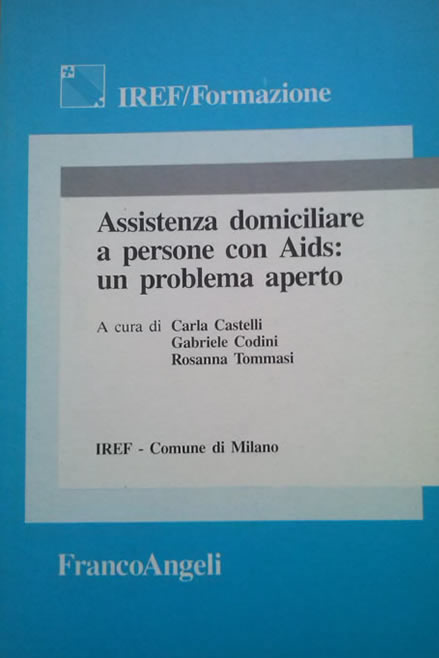
La persona con Aids e il suo contesto di vita
Assistenza domiciliare a persone con Aids: un problema aperto, Franco Angeli, Milano, 1992
Vivere con l’Aids
Per alcune persone la diagnosi sembra giungere del tutto inattesa, in relazione alla comparsa di patologie che per la prima volta impongono la necessità di un chiarimento riguardo allo stato sierologico. Per altre, sieropositive da tempo o interessate a malattie correlate all’Hiv, la diagnosi è più una conferma o un altro modo di definire la situazione. Essa è inserita in un continuum che ne modifica in parte il senso.
In generale, comunque, la persona è in grado di prevedere le dichiarazioni del medico e ha già avuto modo di esercitarsi nel ruolo di malato. Non si dà mai, infatti, il caso di un’ignoranza della natura della propria malattia, semmai si verificano sfumature di (in)consapevolezza rispetto alla gravità e alle implicazioni delle patologie pregresse o in corso.
Rivelare o tacere la diagnosi è un problema fittizio nell’Aids. Di concerto con medici spesso molto tentati dal profetizzare la morte, è il paziente stesso a prospettare la prognosi (infausta). La Babele dell’opinione pubblica e dei mass-media gli fornisce il linguaggio e tutte le figure retoriche. Rimane da chiedersi cosa venga propriamente diagnosticato o rivelato. Cos’è l’Aids? Chi è una persona con Aids? Occorre senz’altro cominciare o ri-cominciare a pensarci, rinunciando ai luoghi comuni e a tutte le verità preconfezionate.
La consapevolezza sgradevole della inguaribilità attuale e la prospettiva della morte, unite alla percezione della malevolenza diffusa nel sociale nei confronti dei malati di Aids, generano spesso la sensazione di essere in trappola e non avere scampo, soprattutto nei primi periodi. L’incertezza è l’elemento distintivo della condizione umana dell’Aids, incertezza circa il decorso, la prognosi, l’efficacia dei trattamenti, le reazioni dei partner, gli effetti sui familiari, ecc.
La persona ritiene di avere poco controllo sulla propria vita e scarsissime possibilità di scelta. Ogni attività pare pregiudicata dallo stato di salute o dall’idea della morte. Il senso di impotenza e di inutilità può portare a svalutare e inibire le iniziative personali e i progetti per il futuro. Una considerevole dose di ansietà e tensione, una serie di preoccupazioni ossessive, depressioni e alterazioni dell’umore sono pertanto del tutto giustificate.
L’intensa medicalizzazione che segue alla diagnosi fa sì che la vita sia praticamente centrata intorno all’ospedale e al personale socio-sanitario, con annullamento della dinamica sociale come pure dei programmi privati e dell’attività professionale. In tali circostanze una perdita d’identità e di controllo è inevitabile. Ovunque e comunque la persona rischia di essere soltanto un malato (quel malato) ed è chiamata ad identificarsi anima e corpo con la malattia, che costituisce l’oggetto concreto dell’interesse e dell’attenzione sia del medico sia dell’entourage.
L’Aids non suscita simpatia, è stata ed è una malattia stigmatizzante che espone a gravi mortificazioni. Per molti finisce per rappresentare l’ulteriore e definitiva conferma di una cattiva condotta e della propria inadeguatezza come esseri umani. Sicché sono frequenti vissuti di colpevolezza, rimorsi e auto-recriminazioni, nel contesto di una stima di sé che soggiace a notevoli contraccolpi e spesso già piuttosto compromessa nel passato.
Ritirarsi dalla vita sociale e professionale diviene quasi una necessità, soprattutto per coloro che presentano segni evidenti del sarcoma di Kaposi, dimagrimento e declino fisici evidenti. In tal caso, infatti, ci si sente sgradevoli e troppo coscienti di sé per affrontare il mondo proprio mentre si espone la propria vulnerabilità e si mettono in mostra stigmate facilmente riconoscibili.
Il timore delle reazioni altrui e del rifiuto in tutte le sue sfumature imbastisce la trama di relazioni mistificatorie cui il soggetto partecipa solo in apparenza, andando lentamente o rapidamente alla deriva con le proprie inconfessabili verità. Del resto, defezioni e incomprensioni alimentano la tendenza all’isolamento. Reale o immaginario, esso pervade il vissuto e sovrasta il senso di sé, anche perché le condizioni di salute impongono una modificazione dello stile di vita tale da comportare l’abbandono di alcune attività prima condivise.
L’inabilità al lavoro può sottrarre fonti di gratificazione ed accentuare il vissuto di fallimento. La paura di contagiare persone care e la consapevolezza d’esser percepiti, al di là delle buone intenzioni, come “pericolosi”, mettono a dura prova la fiducia in se stessi. Finché è possibile molti cercano di evitare la dichiarazione ai congiunti, in particolare ai genitori. Convivono così con un segreto che, per esser mantenuto, rischia di erodere la gran parte delle energie interiori e di impedire l’uso ottimale del tempo a disposizione.
Un certo grado di depressione è del tutto naturale, in rapporto alle molte perdite (salute, realizzazioni socio-professionali, socialità, sessualità ed affetti). L’alternanza di pessimismo e speranze è comune e comprensibile. A periodi di ottimismo e benessere possono seguire momenti di cupa disperazione allorché le circostanze di vita quotidiana fanno emergere le difficoltà di ripresa o fiaccano la capacità di resistenza.
L’Aids richiede, in effetti, una grande flessibilità sia a livello emozionale che cognitivo, per conservare la funzione dell’adattamento passando da un gradino appena conquistato a quello successivo quando le condizioni esistenziali o di salute mutano. La paura dell’emarginazione e dell’ostracismo è sempre in primo piano e procura molte sofferenze. Poter essere esclusi dal consorzio civile fa balenare persino l’idea dell’esclusione dalla specie (le problematiche procreative sembrano offrirne una convalida).
Sentirsi in desiderati e sgraditi è un’esperienza tremendamente amara, la comunità, gli altri, hanno un’importanza enorme, nel bene e nel male, per chi soffre di una crisi radicale dell’identità
Problematiche dei congiunti
In molte circostanze il partner e/o i famigliari (una o più persone) assumono il ruolo di assistente a tempo pieno. Tra i membri del rapporto l’osmosi dei sentimenti e dei vissuti è la regola; con molte differenze tuttavia circa i contenuti e gli effetti delle transazioni ad alta tensione emotiva. L’Aids può rappresentare l’occasione per manifestare opposizioni e rifiuti prima solo minacciati; oppure per presentare il conto di anni di incomprensioni e recriminazioni. Senza esclusione di colpi i famigliari giungono a scambiarsi accuse ed umiliazioni, apparentemente senza ombra di pietà.
Molte relazioni famigliari vengono svelate nelle loro trame essenziali, in cui sotto le mentite spoglie dell’affetto sono stati consumati abusi e violazioni d’ogni tipo. Famiglie che non sono mai riuscite a convivere con il loro membro ora malato, devono improvvisamente farsene carico e per giunta di buon grado. D’altro canto, situazioni affettive (famigliari e amorose) in precedenza stagnanti in moduli poco significativi e superficiali, possono trovare nella nuova prova l'opportunità per un salto di qualità, per l’approfondimento della comunicazione fino a livelli inimmaginabili in passato e piacevolmente sorprendenti per gli interessati.
La relazione si gioca fondamentalmente sul piano dell’accettazione, desiderata ma sempre messa in discussione e sospettata. È vitale supporre di poter essere accettato dalle persone significative dal punto di vista affettivo, sapere che si incontrerà la disponibilità ad aiutare è essenziale per chi ha l’Aids, poter contare sull’altro è la condizione per continuare a credere nello scambio umano, per poter ancora dare e ricevere.
Drammatica, di converso, è la paura che non ci sia più spazio per sé, ora che si è portatori di una verità tanto ingombrante (fatta di tante verità condensate e singolarmente sofferte). Il timore di procurare un’angoscia intollerabile nel congiunto e di pesare in modo irrimediabile, non risarcibile e assoluto, procurano notevole disagio e coartano gli spazi della relazione affettiva. La delusione e la frustrazione facilmente si tramutano in aggressività. D’altronde, la regressione come meccanismo di difesa è evidente in modo particolare nei rapporti con i famigliari.
Anche i congiunti hanno un grande bisogno di “capire”, non tanto nel senso di possedere informazioni dettagliate sulla malattia e sulle regole d’igiene nella convivenza, quanto piuttosto nel senso di dare un significato a tutto quello che accede e trovare una modalità di convivenza. Altrimenti non resta che un vissuto di costrizione e tragedia per una calamità che può essere solo subita con connotati punitivi e la disperazione che accompagna ogni sofferenza cui non si può dare un senso.
L’insistenza nei confronti dei sanitari per ottenere precisazioni e dati o le richieste di intervento di personale d’area psico-sociale costituiscono solo in parte l’espressione del disorientamento di fronte alla malattia e dell’incompetenza nei problemi materiali. La ricerca di punti di riferimento è spesso senza successo perché in realtà non prevede risposte effettive sul piano della concretezza; l’obiettivo è una sorta di bussola interiore che consenta di mantenere la rotta e l’equilibrio. La domanda insistente nascosta sia dietro l’apprensione e la paura sia dietro il silenzio ostinato, riguarda l’atteggiamento che è possibile adottare verso la persona malata: come “trattarla”, come comportarsi, quali sentimenti e vissuti sono autorizzati?
I pensieri e le emozioni dei congiunti ruotano fondamentalmente attorno ai due poli del sentimento di colpa e di quello dell’abbandono. La colpa è presente in tutti, anche nei migliori rapporti. L’angoscia che essa provoca può portare a cercare in tutti i modi di rifiutarla. Il parente non sa come reagire poiché parte dalla negazione di quel che prova. Allora può tentare di scaricare su altri la colpa che non può tollerare dentro di sé, oppure cercare di esserne assolto.
Altrettanto importante il tema dell’abbandono. Sovente si è più preoccupati dello stato in cui ci si verrà a trovare con la perdita del congiunto, che non della condizione umana di quest’ultimo. Ciò provoca un’angoscia profonda (come farò senza di lui?) e il conseguente rifiuto di cominciare a pensare al lutto. Ogni perdita riproduce la dinamica e le vicende del legame con le figure parentali.
Tale situazione riattiva le precedenti esperienze di separazione e mette in luce se e quanto il percorso di acquisizione di un’identità separata e autonoma sia giunto a buon fine (stabilità interiore dei cosiddetti oggetti primari). Le molte approssimazioni e i tanti rammendi dello sviluppo psicologico spiegano i risultati per lo più parziali e le dolorose ripetizioni di difese inefficaci. Sarà più difficile separarsi laddove sono mancate le opportunità di individuazione e maturazione affettiva. La separazione infatti è già implicita nella relazione e precede l’effettivo venir meno della persona cara. È pur vero che al lutto e all’amore non compensativo non viene dedicato né tempo né impegno; non esiste una cultura della relazione e ciascuno, lasciato a se stesso, fa come può improvvisando nei momenti cruciali della vita.
Il parente o il partner può caparbiamente attaccarsi all’idea della immortalità del congiunto, non ammettendo che possa davvero morire o rifiutando di credere che ci sia poco o nulla da fare, pensando in verità soprattutto a se stesso, al proprio disagio e malessere. Quindi la persona malata non deve morire per consentire all’altro di conservare stabilità.
È possibile pure una situazione intermedia in cui ci si colloca a metà tra l’impossibilità dell’abbandono e l’impossibilità di quel che avverrà “dopo”. Non saper accettare la separazione e non voler rinunciare all’appropriazione dell’altro rendono più difficile e accidentato l’accompagnamento. Trovare una giusta distanza e darsi la libertà restano infatti gli obiettivi di una relazione paritetica.
Persone con Aids e malati di Aids
Sentirsi etichettato come “vittima” ha un effetto annichilente. Si ha l’impressione di un vano dibattersi di pesci sulla sabbia, significa che il mondo non vuole avere più nulla a che fare con te e che non puoi che subire, in silenzio e senza far troppo rumore, la catastrofe che si è abbattuta su di te.
Negli ospedali e nei luoghi di cura regna la malattia Aids e si incontrano i pazienti che ne sono affetti; ma altrove e soprattutto a casa si incontra una persona con Aids. A maggior ragione perché si tratta di una condizione cui la medicina può offrire solo risposte parziali e che non può quindi venir ridotta all’aspetto della patologia fisica.
Le persone allora vanno incoraggiate a non sacrificare l’identità al male, a non identificare la personalità con la malattia, proprio grazie all’accettazione più realistica possibile della loro condizione. Accettare cioè di essere malati e non la malattia in sé, in modo che si produca una consapevolezza articolata dello status acquisito.
Oggi, invece, i malati di Aids brillano soltanto di luce riflessa. Di quella dei medici, per esempio, i luminari in particolare; ma pure di quella dei volontari che ne fanno mostra orgogliosi, i buoni moderni. Al contrario la luce delle persone con Aids è occultata, nascosta e screditata, quando riesce a balenare attraverso gli spiragli del cemento armato dell’assistenzialismo e della compassione programmata (specie di matrice cattolica).
Non c’è spazio per le persone con Aids, bensì solo per il fenomeno Aids, non c’è modo di essere e restare persone, di venire accolti nel contesto relazionale in quanto tali. Si viene tenuti “fuori” dalla quotidianità e dalla normalità. Gli altri non fanno spazio nella realtà, se mai serrano le fila, fanno palizzata e catapultano lontano. Tutti sono portati a situare “altrove” la possibilità dell’Aids come esperienza concreta, sicché chi è direttamente coinvolto si trova privo di spazio vitale e di dimensione esistenziale, oltre che di tempo.
L’alternativa è accettare di essere “tipico”, un paziente da manuale, così si potrà ottenere una collocazione (forse una riabilitazione), benché ciò equivalga in pratica ad una deportazione nei reparti ospedalieri o ad una segregazione (esilio) tra le mura domestiche. L’ambiente sociale ed affettivo infatti può favorire o impedire l’essere-nel-mondo della persona con Aids, tiene in vita o toglie la vita.
Tranne casi fortunati, assistiamo per lo più a confinamenti in riserve non prive di vantaggi secondari ma neppure esenti da umiliazioni, persino ontologiche. Eppure, nonostante tutto, ogni soggetto conserva il proprio stile, il proprio tratto caratteristico, l’originalità e l’unicità. A dispetto delle attese, ci sono persone con Aids che vivono nel mondo, la loro casa è il mondo intero. Praticano la solidarietà e convivono in modo attivo con la condizione propria e altrui, facendole la leva di un processo di straordinaria umanizzazione, di cui beneficia la società nel suo complesso.
Uno sguardo rispettoso ed onesto porta a constatare che la persona con Aids cerca o ha bisogno soprattutto di conservare la propria identità. Il senso della dinamica della malattia e della vita sta in questa lotta per preservare l’identità di essere umano di fronte ad avversità e minacce d’ogni genere.
Nell’Aids c’è sempre il risveglio di una dimensione trascendente (spirituale), che innesca un cammino di cambiamento poche volte incoraggiato dagli altri. Compare pure l’opportunità di compiere verso sé stessi un atto di amore: la scelta della propria necessità, cioè l’accettazione di sé e dei propri limiti, compreso il limite della morte.
Mattia Morretta (1992)
